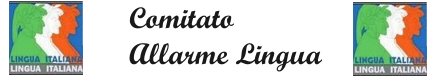Delle lingue europee **
Il problema linguistico è un problema di grandissima importanza per l'avvenire dell'Europa, al di là di quello delle istituzioni europee, e mi sembra che, al momento, la questione non è stata approfondita, né dibattuta, a livello delle istituzioni responsabili. C'è una deriva verso l'inglese e se delle decisioni sono state prese, a qualsiasi livello, si tratta di decisioni occulte e di parte, prese in assenza e all'insaputa delle parti interessate. Ora, tenuto conto dell'importanza di questo tema, ogni decisione dovrebbe essere presa con cognizione di causa e con la partecipazione ed il consenso espliciti dei cittadini europei e di tutte le forze in gioco.
Va da sé che i dibattiti tra funzionari, anche se essi rappresentano, senza alcun dubbio, una delle tante parti interessate, non possono che apportare degli elementi di riflessione al dibattito generale. In questa ottica, vorrei mettere in evidenza due questioni importanti che si pongono, tra le altre, quando si solleva il problema delle lingue di lavoro delle istituzioni europee: la questione culturale e la questione democratica, per poi tirare le conclusioni quanto a ciò di cui, a mio parere, l’Europa ha bisogno.
La questione culturale
Una lingua è sempre e, innanzitutto, l'espressione di una cultura, forse anche l'espressione più completa di ogni specifica cultura.
Si considera, in genere che, all’interno delle istituzioni europee, esistono «grossomodo» due grandi blocchi, quello che si identifica con la cultura latina e quello che si identifica con la cultura anglosassone. C'è tuttavia, in questo assioma, una grande lacuna dove si dimenticano molte cose e in particolare la cultura germanica che, nella sua «forma mentis», si avvicina più alla cultura latina che a quella anglosassone e che è, in ogni caso, una cultura a sé: fertile, radiosa, umanistica, culla della cultura mitteleuropea. Questa cultura, che le vicende delle due guerre mondiali hanno sacrificato e occultato, in ogni senso, rendendola responsabile, attraverso un giudizio sommario, di certe devianze politiche, è sempre viva e feconda, radicata in un vasto tessuto rurale ed urbano di una ricchezza e di una esuberanza straordinarie. Sarebbe un errore storico imperdonabile privare l'Europa della sua dimensione mitteleuropea relegando questa ad un rango secondario. L'adesione di certi paesi dell'Europa centrale, peraltro, non può che dare un nuovo slancio a questa cultura e destinarla ad avere un ruolo sempre più importante. Va da se che l'Europa ha bisogno, anche e soprattutto, della sua dimensione greco-latina che è stata e resta la placenta della civiltà occidentale.
Le istituzioni europee, nella messa in pratica effettiva della democrazia e dello stato di diritto, non possono prescindere dalla razionalità, dalla logica e dal rigore del pensiero greco-latino che non può trovare la sua vera espressione e salvaguardare i suoi valori attraverso uno strumento tanto imperfetto quale può esserlo una lingua appartenente ad un'altra forma di pensiero. Incombe dunque alle istituzioni europee e a tutte le parti in causa di vegliare ad evitare l'impoverimento del pensiero nelle sabbie mobili del pragmatismo della cultura anglofona. Incombe loro di vegliare, altresì, a non scivolare nel pensiero unico della globalizzazione attraverso l’uso di una sola lingua che impone la sua cultura.
L'Europa, nella sua dimensione linguistica e culturale, se vuole darsi una vera opportunità di riempire il suo ruolo e di esistere a livello mondiale, non può costruirsi ad immagine di altri imperi e di altre potenze, in altre regioni del mondo, per le quali la grande carta vincente e il segreto del successo sono il livellamento verso il basso e l'assenza di un impegno etico culturale che si riconosca nei valori umanistici, nel rispetto di tutte le culture, nella solidarietà sociale. L'Europa deve tenere conto della «sua» realtà e dare lo spazio appropriato e necessario alle molteplici culture che ne costituiscono la ricchezza e l’«unicità». Tenere conto di questa ricchezza e di questa «unicità» significa che l'Europa non può funzionare sulla base di una sola lingua, nella fattispecie l'inglese, se non vuole innescare il meccanismo di un appiattimento suicida ed inaccettabile.
Ma l'Europa, per fare questo, non può restare inerte, deve riflettere, decidere, pianificare, agire.
La questione democratica
Le istituzioni europee perseguono degli obiettivi che tendono all’integrazione nei campi più vasti e diversificati, spesso altamente tecnici, e producono delle regolamentazioni che hanno un impatto sulla vita dei cittadini. Talvolta, queste regolamentazioni sono direttamente applicabili all’interno del sistema legislativo e regolamentare nazionale. Tenuto conto di queste caratteristiche uniche a livello delle organizzazioni internazionali esistenti, i Padri fondatori, allo scopo di porre tutti i cittadini su un piano di uguaglianza, di fronte alle istituzioni, ai regolamenti che emanano, alle opportunità che creano, avevano deciso che tutte le lingue della Comunità Europea avessero il rango di lingue ufficiali e di lingue di lavoro. Per molti anni, pur con una predominanza del francese che si poteva giustificare con il fatto che il francese è la lingua veicolare di Bruxelles, capitale dell’Europa e sede delle sue istituzioni, tutte le lingue degli Stati Membri erano di uso corrente, in seno a tutte le istituzioni europee e in tutte le forme d’espressione: dai documenti di lavoro all’interpretazione per le riunioni, dai formulari per qualsiasi procedura amministrativa alle indicazioni ad uso dei visitatori, dal bollettino di informazione dei funzionari alle comunicazioni personali per i cittadini europei che chiedevano informazioni su l’uno o l’altro tema. Le unità, che costituiscono la base del sistema gerarchico-amministrativo, erano scrupolosamente multilingui e predisposte in modo tale da poter far fronte, dal punto di vista linguistico, a tutte le eventualità. Poco a poco, con il progressivo rimpiazzarsi del sistema inglese al sistema preesistente di stampo latino, questo schema trasparente e ordinato è stato sovvertito a un punto tale che oggi quando se ne parla sembra una cosa strana, un’originalità.
Recentemente, sotto la presidenza di Romano Prodi, per dichiarate necessità interne di carattere pratico, la Commissione Europea, ha deciso di ridurre a tre le lingue di procedura: tedesco, francese, inglese, senza tuttavia toccare allo statuto di «lingua ufficiale e lingua di lavoro» delle altre lingue, per il semplice fatto che non rientra nelle sue competenze e che solo il Consiglio di Ministri del‘Unione può farlo deliberando all’unanimità. Ciononostante, queste tre lingue sono oggi considerate “de facto” le lingue di lavoro della Commissione. Da notare che la proposta iniziale era stata quella di ridurre le lingue di procedura al solo inglese e che soltanto in seguito alle vive proteste dei Ministri degli Affari Esteri Francese e Tedesco la Commissione Prodi ha ripiegato sulle tre lingue. In questa circostanza, non si capisce perché mai il Governo Italiano non si sia manifestato essendo l’Italia uno dei quattro grandi Stati Membri dell’Unione e Membro Fondatore della Comunità Europea.
Questa limitazione dell'uso delle lingue, all’interno dei servizi costituisce, in ogni caso, una distorsione, in termini di democrazia e di diritti umani perché ha come conseguenza di mettere in pratica una discriminazione di fatto nei confronti di certi Paesi e di certi cittadini, ponendone d’ufficio altri in posizione privilegiata. Questo fatto è tanto più grave e inaccettabile in quanto i criteri di scelta delle lingue non sono né chiari, né obiettivi, né univoci, né giustificati e tantomeno stabiliti in un’ottica di democrazia e d’interesse generale.
In questa situazione, poco esaltante, restava, tuttavia, salva la nozione di cultura, ed in ogni caso il diritto degli Stati Membri e dei loro cittadini di comunicare con la Commissione e con le altre istituzioni europee nella loro lingua nazionale. All'interno delle istituzioni, i funzionari meno privilegiati potevano riconoscersi nell’una o nell'altra cultura, trovarvi i loro punti di riferimento ed adattarsi ad una forma di espressione dove, indipendentemente dalla lingua e dalle parole utilizzate, la «forma mentis» e il contesto culturale nei quali si riconoscevano restavano validi. Una lingua, in effetti, non è unicamente costituita dalle parole con le quali si esprime ma anche dal contesto da cui trae le sue origini, dai valori e dalle forme di pensiero, dal cammino che ha percorso, in sintesi dalla sua storia e dai valori che gliene sono restati.
Al momento attuale, però, tutto ciò diventa difficile, la cultura anglo-americana ed i suoi cittadini, le loro “lobbies”, le loro strutture si comportano in guisa di etnie superiori e considerano di avere il privilegio, unico, di parlare quella che è di diritto «la» lingua planetaria. C'è, in questo atteggiamento, un equivoco fondamentale perché, in effetti, in seno alle istituzioni europee e in tutto ciò che a queste si riferisce, non si opera a livello mondiale ma a livello europeo. A un livello in cui un certo numero di paesi dell'Europa lavorano insieme allo scopo di integrarsi progressivamente fino a formare un solo corpo, una unica potenza. In questo contesto, le lingue di livello mondiale non hanno un loro posto, nessun "diritto di cittadinanza” particolare. Al livello europeo occorre privilegiare le lingue che illustrano la specificità dell’Europa, occorre imporle ai nostri interlocutori ed ai nostri “partenaires” per indurli a giocare nel nostro campo e mettere fine alla costrizione che è imposta ai nostri uomini politici, ai governanti e ai dirigenti dell’Europa intera di giocare tutti gli incontri fuori casa.
La salvaguardia di questa specificità è un qualcosa che è dovuto ai cittadini europei, per evitare il pericolo di porre nella culla dell'Europa riunificata il germe del conflitto e della discordia. Non bisogna mai dimenticare che le popolazioni sono capaci di massacrarsi a vicenda, senza tregua per difendere la loro cultura, una cultura che può trovare espressione nella religione, nella lingua, in una diversa concezione del vivere insieme. Gli esempi tragici di conflitti insolubili, sotto i nostri occhi, sono molteplici e multiformi e non hanno bisogno di essere ricordati.
Nonostante ciò, la lingua e la cultura anglo-americana dispongono di sostenitori e di promotori potenti che non si fanno alcuno scrupolo di disporre dell’uno o dell'altro strumento di lavoro e di comunicazione o addirittura della pubblica istruzione per fare della pulizia etnico linguistica o per favorire la colonizzazione del proprio Paese.
Gli anglofoni, in genere, conoscono una sola lingua che impongono agli altri, i quali “altri” devono dibattersi, non solo a captare un pensiero che non corrisponde alla loro “forma mentis” ma a tradurre, per di più, il loro stesso pensiero attraverso una lingua che non ne è lo strumento adeguato. Nella mia qualità di funzionario europeo, mi è capitato spesso che, durante una riunione, l'anglofono di turno dichiarasse non solo di non parlare il francese, lo spagnolo ecc. ma di non essere neanche in grado di comprenderlo. In questi casi, non resta nient’ altro da fare che mettersi al regime inglese anche allorché l'anglofono di turno è, eventualmente, il solo esemplare di questa razza privilegiata e che gli altri sono tutti dei latini che potrebbero, molto più vantaggiosamente, per tutti, esprimersi in francese, in italiano, in spagnolo, o magari parlare ognuno la propria lingua comprendendosi reciprocamente. In queste occasioni, generalmente, l’atteggiamento anglofono, ancor di più se si tratta di un anglofono non di lingua madre, è così arrogante e la sensazione di coercizione è tale che rasenta l'intimidazione e nessuno osa dire che non vuole o che non può parlare in inglese.
Un semplice riflesso di giustizia e di equità suggerisce che è giunto il momento di mettere fine a queste pratiche poco democratiche in seno alle istituzioni europee che si vantano di essere le più democratiche del mondo. Non se ne può più del fatto che certuni debbano sempre fare il ruolo degli schiavetti negri che non sono in grado di esprimersi bene, perché sistematicamente costretti ad esprimersi in una lingua che non è la loro, allorché altri pretendono di esprimersi, leggere, scrivere, formarsi ed informarsi sempre e solamente, nella loro propria lingua. È ancora più inaccettabile che i cittadini degli Stati membri quando si rivolgono, alla Commissione ed alle altre istituzioni europee, se vogliono essere presi in considerazione, per avere delle notizie, nei settori più tecnici e diversificati, debbano scrivere in inglese e/o accontentarsi di una risposta in inglese.
L’attuale situazione, per quanto occultata e strisciante, non ha niente da invidiare a quella che ha visto nascere l’ideologia nazista. E’ importante e necessario prendere coscienza del fatto che siamo in presenza di una nuova forma di colonizzazione, la colonizzazione linguistica e culturale, attraverso la quale gli anglo-americani pianificano, la scomparsa di tutte le altre culture, delle culture più antiche e fiorenti, ovvero la culla della civiltà occidentale. Coloro che sono responsabili di questa deriva, per interesse o per negligenza, devono essere coscienti della responsabilità che si assumono e del fatto che l’unilinguismo porta nel suo seno il cancro del “pensiero unico”, vale a dire, del pensiero morto.
Una politica linguistica per l’Europa.
Nell'immediato, un metodo per ovviare, almeno in parte, a questo grave problema e ristabilire un minimo di democrazia, in seno alle istituzioni europee, sarebbe di mettere in atto, a scopo di esemplarità, un certo numero di provvedimenti:
1) rispettare anzitutto le lingue dei Paesi in cui siedono le istituzioni europee e le loro emanazioni, al fine di integrarvisi armoniosamente e non come l'enclave di una élite colonizzatrice,
2) esigere che tutti i nuovi funzionari possano, se non parlare, almeno comprendere le tre lingue attualmente adottate come lingue di procedura, affinché ogni funzionario possa avere, in pratica e concretamente, la scelta della lingua di lavoro, allo scopo di fornire all’Europa in marcia delle prestazioni di qualità e non delle riflessioni confuse e rattoppate perché obbligato ad esprimersi in una lingua che non corrisponde alla sua cultura,
3) migliorare, ingrandire, valorizzare i servizi linguistici ( traduzione e interpretariato), in seno alle istituzioni europee, farne dei centri di eccellenza al servizio del cittadino europeo nella misura in cui, nel processo di integrazione nel quale siamo impegnati, costituiscono servizi di interesse pubblico di prima necessità,
4) adottare un codice di buona condotta nell'uso delle lingue ufficiali, in seno alle istituzioni europee, in assenza del quale c'è il rischio di abusi, di illegalità e di sconfinamenti nell'arbitrarietà.
Nessuno, in ogni caso, in seno alle istituzioni e all’interno degli Stati Membri, dovrebbe mai essere obbligato a formarsi, ad informarsi, ad esprimersi, per iscritto o oralmente, in una lingua che non appartiene alla cultura nella quale si è formato e nella quale si riconosce. In mancanza di ciò e delle regolamentazioni appropriate per renderlo effettivo, il processo di integrazione europea sarebbe portatore di un deficit democratico grave, generatore potenziale di conflitti insolubili.
A breve termine, il sistema linguistico deve essere rivisto, allargando il numero delle lingue di lavoro, in un'ottica di cultura e di democrazia. È, tra l’altro, sorprendente ed inconcepibile che l'italiano, lingua di un grande Paese fondatore che ha impregnato della sua cultura l'Europa ed il mondo, sia dimenticato e trattato come una lingua “minore”. Per preservare la sua civiltà, i suoi valori, le sue creazioni, il suo splendore, l'italiano deve avere il suo posto, nel lavoro quotidiano che si svolge nel cuore dell’Europa, la concepisce e la forgia. Argomenti simili o equivalenti possono essere avanzati per lo spagnolo.
Il sistema linguistico attuale non è equo né giusto. L’Europa comunitaria ha necessità urgente di una politica linguistica degna di questo nome. In questo ambito, bisognerà porsi il problema della precisione e dell’efficacia delle differenti lingue per i diversi bisogni e per tradurre certi concetti nonché del loro ruolo nella strutturazione del pensiero.
Occorrerà, infine, porsi anche il problema di “formare i giovani europei”: quali lingue, come e perché ma, soprattutto, quando. Va da sé, che questo genere di soluzioni non trovano la strada da sole, richiedono un impegno congiunto di tutte le parti interessate. Uno impegno per dare una testimonianza concreta di apertura e di democrazia, l’impegno necessario per passare dall'unilateralità alla reciprocità e per dare corpo ad una vera Comunità di culture e di valori, la sola possibile e duratura perché democratica e giusta, quella dell'«unità nella diversità».
Anna Maria Campogrande
** Cet article a été écrit à titre personnel, les opinions qu’y sont exprimées n’engagent que l’auteur elle-même Titre de l’article : DELLE LINGUE EUROPEE
Anna-Maria Campogrande est fonctionnaire de la Commission européenne et membre fondateur de l’Observatoire International de la langue française (OILF) dont elle préside la commission “Relations avec les institutions”. L’OILF, qui siège à Bruxelles, préconise une Europe pluriculturelle et multilingue, respectueuse des réalités historiques et démographiques de la latinité.
Anna-Maria Campogrande souhaite que soit mis un terme au démantèlement des services linguistiques des institutions européennes ainsi qu’à leur externalisation. Elle suggère qu’ils deviennent des centres d’excellence linguistique au service du citoyen et de l’Europe toute entière. Ce nouvel espace, culturel et économique, qui est l’Union Européenne, ne connaîtra d’épanouissement qu’à la condition de donner corps à une authentique communauté de valeurs, soucieuse des particularités de tous ses membres.
Il problema linguistico è un problema di grandissima importanza per l'avvenire dell'Europa, al di là di quello delle istituzioni europee, e mi sembra che, al momento, la questione non è stata approfondita, né dibattuta, a livello delle istituzioni responsabili. C'è una deriva verso l'inglese e se delle decisioni sono state prese, a qualsiasi livello, si tratta di decisioni occulte e di parte, prese in assenza e all'insaputa delle parti interessate. Ora, tenuto conto dell'importanza di questo tema, ogni decisione dovrebbe essere presa con cognizione di causa e con la partecipazione ed il consenso espliciti dei cittadini europei e di tutte le forze in gioco.
Va da sé che i dibattiti tra funzionari, anche se essi rappresentano, senza alcun dubbio, una delle tante parti interessate, non possono che apportare degli elementi di riflessione al dibattito generale. In questa ottica, vorrei mettere in evidenza due questioni importanti che si pongono, tra le altre, quando si solleva il problema delle lingue di lavoro delle istituzioni europee: la questione culturale e la questione democratica, per poi tirare le conclusioni quanto a ciò di cui, a mio parere, l’Europa ha bisogno.
La questione culturale
Una lingua è sempre e, innanzitutto, l'espressione di una cultura, forse anche l'espressione più completa di ogni specifica cultura.
Si considera, in genere che, all’interno delle istituzioni europee, esistono «grossomodo» due grandi blocchi, quello che si identifica con la cultura latina e quello che si identifica con la cultura anglosassone. C'è tuttavia, in questo assioma, una grande lacuna dove si dimenticano molte cose e in particolare la cultura germanica che, nella sua «forma mentis», si avvicina più alla cultura latina che a quella anglosassone e che è, in ogni caso, una cultura a sé: fertile, radiosa, umanistica, culla della cultura mitteleuropea. Questa cultura, che le vicende delle due guerre mondiali hanno sacrificato e occultato, in ogni senso, rendendola responsabile, attraverso un giudizio sommario, di certe devianze politiche, è sempre viva e feconda, radicata in un vasto tessuto rurale ed urbano di una ricchezza e di una esuberanza straordinarie. Sarebbe un errore storico imperdonabile privare l'Europa della sua dimensione mitteleuropea relegando questa ad un rango secondario. L'adesione di certi paesi dell'Europa centrale, peraltro, non può che dare un nuovo slancio a questa cultura e destinarla ad avere un ruolo sempre più importante. Va da se che l'Europa ha bisogno, anche e soprattutto, della sua dimensione greco-latina che è stata e resta la placenta della civiltà occidentale.
Le istituzioni europee, nella messa in pratica effettiva della democrazia e dello stato di diritto, non possono prescindere dalla razionalità, dalla logica e dal rigore del pensiero greco-latino che non può trovare la sua vera espressione e salvaguardare i suoi valori attraverso uno strumento tanto imperfetto quale può esserlo una lingua appartenente ad un'altra forma di pensiero. Incombe dunque alle istituzioni europee e a tutte le parti in causa di vegliare ad evitare l'impoverimento del pensiero nelle sabbie mobili del pragmatismo della cultura anglofona. Incombe loro di vegliare, altresì, a non scivolare nel pensiero unico della globalizzazione attraverso l’uso di una sola lingua che impone la sua cultura.
L'Europa, nella sua dimensione linguistica e culturale, se vuole darsi una vera opportunità di riempire il suo ruolo e di esistere a livello mondiale, non può costruirsi ad immagine di altri imperi e di altre potenze, in altre regioni del mondo, per le quali la grande carta vincente e il segreto del successo sono il livellamento verso il basso e l'assenza di un impegno etico culturale che si riconosca nei valori umanistici, nel rispetto di tutte le culture, nella solidarietà sociale. L'Europa deve tenere conto della «sua» realtà e dare lo spazio appropriato e necessario alle molteplici culture che ne costituiscono la ricchezza e l’«unicità». Tenere conto di questa ricchezza e di questa «unicità» significa che l'Europa non può funzionare sulla base di una sola lingua, nella fattispecie l'inglese, se non vuole innescare il meccanismo di un appiattimento suicida ed inaccettabile.
Ma l'Europa, per fare questo, non può restare inerte, deve riflettere, decidere, pianificare, agire.
La questione democratica
Le istituzioni europee perseguono degli obiettivi che tendono all’integrazione nei campi più vasti e diversificati, spesso altamente tecnici, e producono delle regolamentazioni che hanno un impatto sulla vita dei cittadini. Talvolta, queste regolamentazioni sono direttamente applicabili all’interno del sistema legislativo e regolamentare nazionale. Tenuto conto di queste caratteristiche uniche a livello delle organizzazioni internazionali esistenti, i Padri fondatori, allo scopo di porre tutti i cittadini su un piano di uguaglianza, di fronte alle istituzioni, ai regolamenti che emanano, alle opportunità che creano, avevano deciso che tutte le lingue della Comunità Europea avessero il rango di lingue ufficiali e di lingue di lavoro. Per molti anni, pur con una predominanza del francese che si poteva giustificare con il fatto che il francese è la lingua veicolare di Bruxelles, capitale dell’Europa e sede delle sue istituzioni, tutte le lingue degli Stati Membri erano di uso corrente, in seno a tutte le istituzioni europee e in tutte le forme d’espressione: dai documenti di lavoro all’interpretazione per le riunioni, dai formulari per qualsiasi procedura amministrativa alle indicazioni ad uso dei visitatori, dal bollettino di informazione dei funzionari alle comunicazioni personali per i cittadini europei che chiedevano informazioni su l’uno o l’altro tema. Le unità, che costituiscono la base del sistema gerarchico-amministrativo, erano scrupolosamente multilingui e predisposte in modo tale da poter far fronte, dal punto di vista linguistico, a tutte le eventualità. Poco a poco, con il progressivo rimpiazzarsi del sistema inglese al sistema preesistente di stampo latino, questo schema trasparente e ordinato è stato sovvertito a un punto tale che oggi quando se ne parla sembra una cosa strana, un’originalità.
Recentemente, sotto la presidenza di Romano Prodi, per dichiarate necessità interne di carattere pratico, la Commissione Europea, ha deciso di ridurre a tre le lingue di procedura: tedesco, francese, inglese, senza tuttavia toccare allo statuto di «lingua ufficiale e lingua di lavoro» delle altre lingue, per il semplice fatto che non rientra nelle sue competenze e che solo il Consiglio di Ministri del‘Unione può farlo deliberando all’unanimità. Ciononostante, queste tre lingue sono oggi considerate “de facto” le lingue di lavoro della Commissione. Da notare che la proposta iniziale era stata quella di ridurre le lingue di procedura al solo inglese e che soltanto in seguito alle vive proteste dei Ministri degli Affari Esteri Francese e Tedesco la Commissione Prodi ha ripiegato sulle tre lingue. In questa circostanza, non si capisce perché mai il Governo Italiano non si sia manifestato essendo l’Italia uno dei quattro grandi Stati Membri dell’Unione e Membro Fondatore della Comunità Europea.
Questa limitazione dell'uso delle lingue, all’interno dei servizi costituisce, in ogni caso, una distorsione, in termini di democrazia e di diritti umani perché ha come conseguenza di mettere in pratica una discriminazione di fatto nei confronti di certi Paesi e di certi cittadini, ponendone d’ufficio altri in posizione privilegiata. Questo fatto è tanto più grave e inaccettabile in quanto i criteri di scelta delle lingue non sono né chiari, né obiettivi, né univoci, né giustificati e tantomeno stabiliti in un’ottica di democrazia e d’interesse generale.
In questa situazione, poco esaltante, restava, tuttavia, salva la nozione di cultura, ed in ogni caso il diritto degli Stati Membri e dei loro cittadini di comunicare con la Commissione e con le altre istituzioni europee nella loro lingua nazionale. All'interno delle istituzioni, i funzionari meno privilegiati potevano riconoscersi nell’una o nell'altra cultura, trovarvi i loro punti di riferimento ed adattarsi ad una forma di espressione dove, indipendentemente dalla lingua e dalle parole utilizzate, la «forma mentis» e il contesto culturale nei quali si riconoscevano restavano validi. Una lingua, in effetti, non è unicamente costituita dalle parole con le quali si esprime ma anche dal contesto da cui trae le sue origini, dai valori e dalle forme di pensiero, dal cammino che ha percorso, in sintesi dalla sua storia e dai valori che gliene sono restati.
Al momento attuale, però, tutto ciò diventa difficile, la cultura anglo-americana ed i suoi cittadini, le loro “lobbies”, le loro strutture si comportano in guisa di etnie superiori e considerano di avere il privilegio, unico, di parlare quella che è di diritto «la» lingua planetaria. C'è, in questo atteggiamento, un equivoco fondamentale perché, in effetti, in seno alle istituzioni europee e in tutto ciò che a queste si riferisce, non si opera a livello mondiale ma a livello europeo. A un livello in cui un certo numero di paesi dell'Europa lavorano insieme allo scopo di integrarsi progressivamente fino a formare un solo corpo, una unica potenza. In questo contesto, le lingue di livello mondiale non hanno un loro posto, nessun "diritto di cittadinanza” particolare. Al livello europeo occorre privilegiare le lingue che illustrano la specificità dell’Europa, occorre imporle ai nostri interlocutori ed ai nostri “partenaires” per indurli a giocare nel nostro campo e mettere fine alla costrizione che è imposta ai nostri uomini politici, ai governanti e ai dirigenti dell’Europa intera di giocare tutti gli incontri fuori casa.
La salvaguardia di questa specificità è un qualcosa che è dovuto ai cittadini europei, per evitare il pericolo di porre nella culla dell'Europa riunificata il germe del conflitto e della discordia. Non bisogna mai dimenticare che le popolazioni sono capaci di massacrarsi a vicenda, senza tregua per difendere la loro cultura, una cultura che può trovare espressione nella religione, nella lingua, in una diversa concezione del vivere insieme. Gli esempi tragici di conflitti insolubili, sotto i nostri occhi, sono molteplici e multiformi e non hanno bisogno di essere ricordati.
Nonostante ciò, la lingua e la cultura anglo-americana dispongono di sostenitori e di promotori potenti che non si fanno alcuno scrupolo di disporre dell’uno o dell'altro strumento di lavoro e di comunicazione o addirittura della pubblica istruzione per fare della pulizia etnico linguistica o per favorire la colonizzazione del proprio Paese.
Gli anglofoni, in genere, conoscono una sola lingua che impongono agli altri, i quali “altri” devono dibattersi, non solo a captare un pensiero che non corrisponde alla loro “forma mentis” ma a tradurre, per di più, il loro stesso pensiero attraverso una lingua che non ne è lo strumento adeguato. Nella mia qualità di funzionario europeo, mi è capitato spesso che, durante una riunione, l'anglofono di turno dichiarasse non solo di non parlare il francese, lo spagnolo ecc. ma di non essere neanche in grado di comprenderlo. In questi casi, non resta nient’ altro da fare che mettersi al regime inglese anche allorché l'anglofono di turno è, eventualmente, il solo esemplare di questa razza privilegiata e che gli altri sono tutti dei latini che potrebbero, molto più vantaggiosamente, per tutti, esprimersi in francese, in italiano, in spagnolo, o magari parlare ognuno la propria lingua comprendendosi reciprocamente. In queste occasioni, generalmente, l’atteggiamento anglofono, ancor di più se si tratta di un anglofono non di lingua madre, è così arrogante e la sensazione di coercizione è tale che rasenta l'intimidazione e nessuno osa dire che non vuole o che non può parlare in inglese.
Un semplice riflesso di giustizia e di equità suggerisce che è giunto il momento di mettere fine a queste pratiche poco democratiche in seno alle istituzioni europee che si vantano di essere le più democratiche del mondo. Non se ne può più del fatto che certuni debbano sempre fare il ruolo degli schiavetti negri che non sono in grado di esprimersi bene, perché sistematicamente costretti ad esprimersi in una lingua che non è la loro, allorché altri pretendono di esprimersi, leggere, scrivere, formarsi ed informarsi sempre e solamente, nella loro propria lingua. È ancora più inaccettabile che i cittadini degli Stati membri quando si rivolgono, alla Commissione ed alle altre istituzioni europee, se vogliono essere presi in considerazione, per avere delle notizie, nei settori più tecnici e diversificati, debbano scrivere in inglese e/o accontentarsi di una risposta in inglese.
L’attuale situazione, per quanto occultata e strisciante, non ha niente da invidiare a quella che ha visto nascere l’ideologia nazista. E’ importante e necessario prendere coscienza del fatto che siamo in presenza di una nuova forma di colonizzazione, la colonizzazione linguistica e culturale, attraverso la quale gli anglo-americani pianificano, la scomparsa di tutte le altre culture, delle culture più antiche e fiorenti, ovvero la culla della civiltà occidentale. Coloro che sono responsabili di questa deriva, per interesse o per negligenza, devono essere coscienti della responsabilità che si assumono e del fatto che l’unilinguismo porta nel suo seno il cancro del “pensiero unico”, vale a dire, del pensiero morto.
Una politica linguistica per l’Europa.
Nell'immediato, un metodo per ovviare, almeno in parte, a questo grave problema e ristabilire un minimo di democrazia, in seno alle istituzioni europee, sarebbe di mettere in atto, a scopo di esemplarità, un certo numero di provvedimenti:
1) rispettare anzitutto le lingue dei Paesi in cui siedono le istituzioni europee e le loro emanazioni, al fine di integrarvisi armoniosamente e non come l'enclave di una élite colonizzatrice,
2) esigere che tutti i nuovi funzionari possano, se non parlare, almeno comprendere le tre lingue attualmente adottate come lingue di procedura, affinché ogni funzionario possa avere, in pratica e concretamente, la scelta della lingua di lavoro, allo scopo di fornire all’Europa in marcia delle prestazioni di qualità e non delle riflessioni confuse e rattoppate perché obbligato ad esprimersi in una lingua che non corrisponde alla sua cultura,
3) migliorare, ingrandire, valorizzare i servizi linguistici ( traduzione e interpretariato), in seno alle istituzioni europee, farne dei centri di eccellenza al servizio del cittadino europeo nella misura in cui, nel processo di integrazione nel quale siamo impegnati, costituiscono servizi di interesse pubblico di prima necessità,
4) adottare un codice di buona condotta nell'uso delle lingue ufficiali, in seno alle istituzioni europee, in assenza del quale c'è il rischio di abusi, di illegalità e di sconfinamenti nell'arbitrarietà.
Nessuno, in ogni caso, in seno alle istituzioni e all’interno degli Stati Membri, dovrebbe mai essere obbligato a formarsi, ad informarsi, ad esprimersi, per iscritto o oralmente, in una lingua che non appartiene alla cultura nella quale si è formato e nella quale si riconosce. In mancanza di ciò e delle regolamentazioni appropriate per renderlo effettivo, il processo di integrazione europea sarebbe portatore di un deficit democratico grave, generatore potenziale di conflitti insolubili.
A breve termine, il sistema linguistico deve essere rivisto, allargando il numero delle lingue di lavoro, in un'ottica di cultura e di democrazia. È, tra l’altro, sorprendente ed inconcepibile che l'italiano, lingua di un grande Paese fondatore che ha impregnato della sua cultura l'Europa ed il mondo, sia dimenticato e trattato come una lingua “minore”. Per preservare la sua civiltà, i suoi valori, le sue creazioni, il suo splendore, l'italiano deve avere il suo posto, nel lavoro quotidiano che si svolge nel cuore dell’Europa, la concepisce e la forgia. Argomenti simili o equivalenti possono essere avanzati per lo spagnolo.
Il sistema linguistico attuale non è equo né giusto. L’Europa comunitaria ha necessità urgente di una politica linguistica degna di questo nome. In questo ambito, bisognerà porsi il problema della precisione e dell’efficacia delle differenti lingue per i diversi bisogni e per tradurre certi concetti nonché del loro ruolo nella strutturazione del pensiero.
Occorrerà, infine, porsi anche il problema di “formare i giovani europei”: quali lingue, come e perché ma, soprattutto, quando. Va da sé, che questo genere di soluzioni non trovano la strada da sole, richiedono un impegno congiunto di tutte le parti interessate. Uno impegno per dare una testimonianza concreta di apertura e di democrazia, l’impegno necessario per passare dall'unilateralità alla reciprocità e per dare corpo ad una vera Comunità di culture e di valori, la sola possibile e duratura perché democratica e giusta, quella dell'«unità nella diversità».
Anna Maria Campogrande
** Cet article a été écrit à titre personnel, les opinions qu’y sont exprimées n’engagent que l’auteur elle-même Titre de l’article : DELLE LINGUE EUROPEE
Anna-Maria Campogrande est fonctionnaire de la Commission européenne et membre fondateur de l’Observatoire International de la langue française (OILF) dont elle préside la commission “Relations avec les institutions”. L’OILF, qui siège à Bruxelles, préconise une Europe pluriculturelle et multilingue, respectueuse des réalités historiques et démographiques de la latinité.
Anna-Maria Campogrande souhaite que soit mis un terme au démantèlement des services linguistiques des institutions européennes ainsi qu’à leur externalisation. Elle suggère qu’ils deviennent des centres d’excellence linguistique au service du citoyen et de l’Europe toute entière. Ce nouvel espace, culturel et économique, qui est l’Union Européenne, ne connaîtra d’épanouissement qu’à la condition de donner corps à une authentique communauté de valeurs, soucieuse des particularités de tous ses membres.